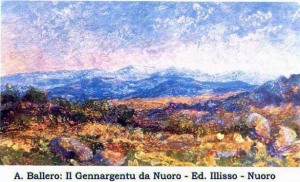« Scrivo per un’infinità di motivi. Per vocazione, anche per continuare un rapporto che un avvenimento e le convenzioni della vita hanno reso altrimenti impossibile, anche per giustificare i miei sedici anni di studi non coronati da laurea, anche per spirito agonistico, anche per restituirmi sensazioni passate; per un’infinità di ragioni, insomma. Non certo per divertimento. Ci faccio una fatica nera. La più facile delle mie pagine esce spensierata da una decina di penosi rifacimenti ».
E’ questa l’unica dichiarazione che Beppe Fenoglio ci ha lasciato nella sua attività di scrittore, attività svolta in un breve arco di vita. L’opera di Fenoglio ambientata in uno spazio temporale e geografico ristretto – dagli anni 30 del secolo scorso fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nella terra d’Alba e delle Langhe – trova il respiro per delineare una storia italiana vera e propria. I suoi racconti formano un’epopea romanzesca e sono la testimonianza di una tensione ideale, di una purezza morale, di una onestà intellettuale di rara esemplarità.
L’addio é uno dei suoi racconti più belli. Il racconto del primo Amore. La poesia del primo perduto Amore.
L’addio
da “Un giorno di fuoco” :
Dopo la terza elementare suo padre lo tolse da scuola, inutilmente il vecchio maestro Alliani venne su fino a Collera per dire a suo padre che era un peccato, che a continuare le scuole quel suo figlio poteva riuscire maestro, o veterinario o speziale. Poteva avere tutto quel pane nelle mani, ma suo padre non poteva dargli il lievito per cominciarlo. Disse al maestro Alliani che sapeva far la firma, scrivere una lettera ai parenti se in casa fosse mancato qualcuno, e per contare, sapeva contare fino a una cifra che non avrebbe mai avuta in soldi. E poi gli disse: “Come volete che lo tenga agli studi, se non posso nemmeno passarvi il caffè a voi che per l’interessamento avete montata una collina, alla vostra età!”.
Suo padre aveva in testa di metterlo subito da servitore su una qualche langa, e dovè ringraziare una pleurite che gli venne nell’autunno se il servizio venne procrastinato. Durante la malattia sua madre fece una pratica per farlo entrare nel seminario di Mondovì, padrone poi lui di prendere la veste o di tornare nella vita con un’istruzione. Ma avevano da offrire troppo poco per venire in qualcosa almeno pari e del seminario non si parlò più. Mentre si aspettava che lui si rimettesse dalla pleurite, faceva le solite cose di quando andava a scuola: tagliar legna, tirar l’acqua al pozzo e soprattutto pascolare.
Pascolare gli piaceva, a differenza degli altri ragazzi che ci pativano tra bestie, erba e nuvole, e passavano il tempo pensando alle mattinate di festa che potevano giocare al pallone ai tetti od alle sere nelle stalle che potevano giocare a carte, con la posta di bottoni, ai pericolosi giochi dei padri. Gli altri ragazzi si chiamavano, da bricco a bricco, con grida selvagge, col solo nome facevano tutto un discorso. Lui, il ragazzo della Collera, non chiamava mai, non sentiva il bisogno di discorrere con nessuno. Il suo stroppo era il più piccolo di tutti, e le pecore erano disciplinate da non richiedere nemmeno una guardata di tanto in tanto, e lui da quando veniva a quando sentiva l’Ave al campanile da Murrazzano pensava e girava gli occhi tutt’intorno. Guardava su a Mombarcaro e giù a San Benedetto, e poi Niella e Bossolasco e la punta del campanile di Serravalle, guardando lungo e profondo nella valle di Belbo, arrivava con gli occhi fin dove per la lontananza le ultime colline non eran più che una nuvola d’incenso in chiesa. E gli faceva effetto pensare che andar da servitore voleva dire anzitutto lasciar questi posti e tutti i giorni se li imprimeva bene negli occhi, era arrivato al punto che chiudeva gli occhi e puntava il dito e riaperti gli occhi il dito era puntato sul campanile del paese fissato per gioco. E c’era sempre un silenzio che lui poteva sentire l’uggiolo del suo cane dalla Collera lontana, legato alla catena trecentosessantacinque giorni all’anno..
A un ragazzo al pascolo non succede mai niente, ma lui non ne soffriva perché proprio mentre era al pascolo si faceva succedere nella testa tutto quel che voleva.
Ma un giorno, successe proprio qualcosa. Per la strada della langa, dritto sul suo prato, vennero un cinque sei ragazze delle cascine tutt’intorno a Murrazzano, che lui conosceva solo di vista. Andavano certo per funghi e portavano arrotolato alla vita il gran grembiale delle loro madri, come per una raccolta mai vista. Lui s’era appiattito sull’erba, come aveva visto spuntar le loro teste per l’erta, ma le ragazze si fermarono proprio sul fosso del suo prato e una gli mandò una voce. Una forza oscura lo teneva contro la terra e per alzarsi fece uno sforzo che anche a lui diede la sensazione di quanto era stato goffo. Venne incontro al fosso, ma non poteva sopportare lo sguardo fisso di quelle cinque ragazze, e pensò bene di girarsi un paio di volte a guardare indietro le sue bestie.
“Tu che sei il ragazzo della Collera” gli fece una di quelle.
“Son proprio io”, disse lui con la voce che gli mancava.
“Tu sei pratico di questi posti più alti dei nostri, dicci dove vengono meglio i funghi”.
Lui parlò, checchezzando, dei boschi sotto Costalunga, e mostrò loro la strada.
Le ragazze accennarono della testa, ma non si muovevano. Forse volevano solo prender fiato dopo l’erta di Monte Berico, ma lui perse la testa e senza fare o dire scappò giù per il suo prato, oltre le bestie, fino in fondo e si intanò nel castagneto. Gli arrivò dietro una sola alta e lunga risata da una di quelle ragazze, e quando lui sentì i loro passi lontanare alzò la testa e tornò sul prato.
Era spaventato e umiliato come se gli fosse capitato qualcosa di vergognoso e che purtroppo non sarebbe finito lì, si rimise giù a sedere col petto premuto da un qualcosa.
Di quelle cinque ragazze lui ne aveva notata, pur col suo sguardo spaventato, una: aveva i capelli biondi e quando girò la testa per seguire il suo dito che segnava Costalunga lui vide che li aveva riuniti dietro in un’unica treccia. Le altre avevano le calze di lana nera, lei invece era a gambe nude, e le sue gambe erano dritte e sottili, quasi senza ginocchio come quelle dei capretti. Ripensandoci, trovò che le aveva preso anche gli occhi, o forse era solo una sua invenzione di dopo, e che erano più profondi e più vecchi di quelli delle altre ragazze. Non doveva mangiare più di quel che mangiava lui.
Cominciò a pensarla, da quello stesso giorno, e tutti i giorni aggiungeva un pezzo alla figura di lei: non poteva pensare più a nient’altro, e questo nuovo motivo gli faceva più ricca e curiosa la vita, lo faceva svegliar più presto e addormentarsi più tardi.
Seppe chi era e il suo nome la domenica dopo: lei era in chiesa e passò poi con le altre alla dottrina. Chiedere gli costò molto, ma il ragazzo di cui si fidò gli disse tutto quel che voleva sapere: si chiamava Nella ed era detta Nella della Mellea perché i suoi avevano in mezzadria la cascina della Mellea, che era la più povera di tutto il territorio di Murrazzano. Ed era sorella di quattro fratelli. Due dei più giovani erano suoi compagni alla dottrina. Ebbene, quei due ragazzi, che prima gli erano lontani come se vivessero dieci colline distante, adesso gli apparivano importanti, perché spartivano con Nella la vita di tutti i giorni e la vedevano fare e la sentivano dire tutto quello che faceva e diceva. Adesso lui si sentiva di difenderli contro Emiliano del Fado, che era il più forte di loro ragazzi, così forte che i vecchi gli pronosticavano un avvenire famoso per sfide e vittorie. Ebbene lui per loro sarebbe andato contro ad Emiliano del Fado che poteva abbatterlo con un dito.
Lungo le settimane lui la pensava tanto che non gli sembrava impossibile che un giorno o l’altro lei gli comparisse davanti, chiamata, portata via da dove stava da quella stessa forza che gliela faceva pensare. Seduto sul prato, gli occhi fissi all’orizzonte ma senza veder niente, aveva la facoltà e la felicità di chiamar Nella e di vederla subito comparire dove lui sceglieva, uscire dal folto del castagneto se lui voleva riceverla immobile, oppure profilarsi sulla strada se lui voleva voltarsi. Nella si muoveva, parlava, stava tutto come voleva lui, con gesti e parole che lui aveva preparato per lei, fatte e dette nella misura e col tono che lui voleva. Diceva lei poche parole, ma davano il via a lunghi discorsi di lui che lei ascoltava in un modo che mai nessun uomo ebbe una ragazza a pendergli dalle labbra così e nessun uomo guardato con occhi più stregati di Nella.
In quel tempo suo padre lo portò con sé alla fiera di Carrù e così lui comprò per Nella un boccettino, spendendoci tutti i suoi dieci soldi, e lo teneva a casa sotto il pagliericcio, aspettando il giorno che avrebbe potuto darglielo e potevano correrci degli anni.
Tutte le domeniche la vedeva alla messa, sempre alla stessa distanza, ma a lui bastava che ci fosse, e vedendola si convinceva che gli bastava, che non avesse il bisogno di parlarle. Solo una cosa gli bruciava di sapere, se era stata lei a ridere quella prima volta dei funghi. Era l’unico suo brutto pensiero, e se ci si fermava sopra allora finiva col dirsi che Nella l’aveva già perduta quel primo giorno.
Venne, a rinforzargli in testa quella disperazione, la festa di San Lorenzo, una festa nella quale egli avrebbe voluto essere sottoterra. Avevano impiantato in piazza i giochi e c’era intorno tutta la gente e ci vide tra i suoi fratelli Nella. C’erano le pignatte e l’albero della salsiccia, e in più un gioco nuovo, quello di prender con la lingua uno scudo d’argento appiccicato al fondo sporco di una casseruola sospesa ad un filo: era sporco di fuliggine e di sterco di gallina. Già alcuni ragazzi ci avevano provato, ma la monetina era sempre là incollata, e quelli se n’erano andati tra la gente che rideva con bestemmie da grandi e sputando e togliendosi lo sporco dalla bocca. Era tremendamente difficile poi, ad ogni leccata la pentola oscillava e tornava in faccia al ragazzo, che l’aspettava inginocchiato su una sedia, come uno che fosse da giustiziare.
Lui si atterrì quando suo padre lo mando a provarcisi. Lui gridò di no. “Perché tu no? Ci si sono provati dei ragazzi che i loro padri possono accecar di soldi il tuo di padre”, disse suo padre. Lui ripetè di no, per Nella, solo per lei, parlava forte mentre suo padre parlava basso perché la gente intorno non sentisse che lui lo sforzava. Lui disse che provava alle pignatte, c’erano dentro salami e uova. Ma suo padre gli disse: “Vai alla moneta, val più lo scudo che tutte le pignatte”. E si mise a gridare per chiedere il passo alla gente, rideva e diceva che suo figlio ce l’avrebbe fatta. Lui passò davanti a Nella, sentendola senza vederla, si inginocchiò davanti alla sedia chiamando dentro sua madre come avrebbe fatto in punto di morte e quando fu pronto dettero l’andi alla pentola. Gli diedero più tempo che agli altri, ma lui per il piangere non vedeva nemmeno la moneta, fuggì rovesciando la sedia, e inghiottendo lo sporco fuggì verso la chiesa. Sentiva dietro di sé la corsa pesante di suo padre e quando fu per essere raggiunto deviò verso il muro della chiesa e ci rimase lì come schiacciato contro da un carro, che piangeva disperato, sporco in faccia e con in bocca quel sapore. Suo padre lo pulì bene col fazzoletto, s’era messo ginocchioni sul selciato per farlo, si guardava in giro e poi gli disse: “Non dirlo a tua madre. Adesso ti porto a casa, ma tu non dirlo a tua madre”.
Ma per lui non contava nulla sua madre, contava la figura con Nella che se aggiunta a quella risata l’aveva persa una volta per tutte.
Ad ogni modo pensava sempre a Nella, e se la sognava persino di notte, ed al mattino se ne ricordava subito e bene, dimodochè passava la giornata con indosso un senso di destino.
Un giorno non potè più star lontano e lasciando le pecore da loro che se i suoi venivano a saperlo l’ammazzavano, calò verso Mellea. Non voleva incontrar Nella, moriva di paura a pensarci, ma voleva veder da vicino il suo tetto e le piante che ci crescevano intorno e sentir l’aria che lei respirava. Ci stette chissà quanto, senza che sentisse un rumore nella casa, o che uno della famiglia uscisse sull’aia. Alzando gli occhi lesse l’ora nel colore dell’aria e spaventato scappò su al suo bricco.
Poi venne a sapere per un discorso che fece a casa suo padre che quel disperato del padre di Nella emigrava in Francia per non crepare a Murazzano di fame e sotto i suoi debiti. Ne aveva parlato all’osteria e aveva già detto quel che avrebbe fatto una volta in Francia, con un po’ di fortuna. Lui avrebbe fatto il vinattiere, i figli da servitori nelle campagne e Nella la filandiera. Aveva venduto tutto il cavià per fare il viaggio.
Lui seppe la mattina che partivano e uscì dal letto e da casa come un topo. Andò a nascondersi dietro una gaggia, prima dell’ultima curva della pedaggera al mare. Aspettò lì e vide poi venir su il carro pieno di masserizie e le persone aggrappate a quelle. Gli passarono davanti e lui vide bene un’ultima volta la treccia unica e il profondo sguardo di lei. Andò dietro per un tratto, avanzando curvo dietro la gaggia. Sul carro erano tutti silenziosi e nessuno si voltava indietro. Prima di voltare nell’ultima curva della pedaggera, il padre fermò il cavallo e disse ai figli: “Figlioli, voltatevi e guardate bene Murazzano perché è l’ultima volta che lo vedete”. Tutti si voltarono in silenzio e lui potè vedere bene Nella. Poi si rivoltarono e l’uomo ridiede al cavallo e se ne andarono. Lui non seguì oltre, perché l’aveva vista bene Nella e poi l’ultima curva della pedaggera era per lui la fine del mondo.
Se ne tornò a casa, così pronto e disposto, adesso, ad andar lontano da servitore.